Fomo, Nomo, Jomo
Come liberarsi da un sentimento vecchio, ma con una sigla che poteva diffondersi solo in un mondo come il nostro.

Nell’aprile del 2017 centinaia di giovani provenienti da tutto il mondo si ritrovarono in un’isola pressoché deserta, senza acqua né cibo, con solo qualche rudimentale tenda in cui trascorrere la notte. Sopraffatti dalla fame e truffati da coloro che li avevano condotti fino a lì, protestarono e si disperarono, facendo arrivare le loro grida di paura in ogni angolo del globo, grazie ai social network. Il mondo inorridì, pretese il loro salvataggio. Le operazioni di recupero cominciarono e nel giro di qualche giorno furono portati tutti al sicuro. Fortunatamente non ci fu nessuna vittima.
L’evento appena descritto è il Fyre Fest, il festival musicale per “ricchi millennials” tenutosi su un’isola delle Bahamas nel 2017, organizzato dall’imprenditore-peracottaro Billy McFarand in società con il rapper decaduto Ja Rule. Il festival doveva servire a promuovere Fyre, un nuovo servizio di booking per artisti, e per mesi fu pubblicizzato come evento-da-non-perdere da influencer e star di Instagram quali Kendall Jenner, Bella Hadid e Emily Ratajkowski (nessuna delle quali vi partecipò di persona).
I biglietti partivano da 500 dollari a persona, fino ad arrivare a 12mila per i posti più prestigiosi. Il risultato fu incredibile: l’organizzazione si rivelò praticamente assente, i palchi mancanti e i deliziosi bar che dovevano dissetare i giovani ricconi distribuivano razioni degne degli ultimi giorni dell’Unione Sovietica. Un epic fail tale da meritare ben due documentari, Fyre Fraud, del servizio di streaming statunitense Hulu, e Fyre: The Greatest Party That Never Happened, prodotto da Netflix, che cercarono di capire il come e il perché di quell’assurda manifestazione di privilegio e cialtroneria.
In termini di aspettative e delusione di tali aspettative, il Fyre Fest è stato un evento dallo straordinario impatto mediatico, paragonabile a quello di disastri come il naufragio del Titanic o lo schianto del dirigibile Hindenburg. Ad affondarlo, però, non fu né un iceberg né l’uso spensierato dell’idrogeno, bensì due composti chimici molto più potenti e pericolosi: l’hype e la Fomo.
Non cercateli nella tabella degli elementi, non li troverete. Sono due parole entrate di recente nel gergo comune, i cui significati ci dicono molto sui nostri tempi. Hype significa letteralmente “montatura” o “gonfiamento”, e indica l’aspettativa del pubblico riguardo a un certo prodotto e fenomeno. Per esempio: “C’è grande hype per il nuovo disco di Rihanna” oppure “l’hype sul nuovo film di Zendaya sta scendendo”.
La Fomo, invece, è uno dei prodotti di scarto dell’hype, una sigla che sta per “Fear Of Missing Out”, che possiamo tradurre letteralmente con ‘paura di perdersi qualcosa’. Quando vi recate a una festa o un evento solo perché sentite di doverlo fare, per timore di perdervi un attimo essenziale della vostra vita; o quando comprate l’ennesimo gadget, nonostante abbiate un armadio pieno di diavolerie elettroniche; quando soffrite perché vedete la foto di un evento al quale vanno tutti tranne voi, ebbene, quella è la Fomo.
Quando vi recate a una festa o un evento solo perché sentite di doverlo fare, per timore di perdervi un attimo essenziale della vostra vita; quando soffrite perché vedete la foto di un evento al quale vanno tutti tranne voi, ebbene, quella è la Fomo.
Ho sofferto parecchio di Fomo nella mia vita. Dopo aver lavorato per un paio d’anni a Milano, nel 2014 sono tornato dalle mie parti, in Veneto, lavorando remotamente per alcune riviste. Da lì, ogni giorno, scrollando Facebook e Twitter, vedevo eventi organizzati a Milano, oppure foto in cui persone “interessanti” venivano taggate mentre si bevevano una birra preparando chissà quale operazione culturale (senza di me!). Qualche anno dopo, ma questa è un’altra storia, il destino mi ha riportato a Milano. “Finalmente,” pensavo, “sono a un passo da tutti quegli eventi, aperitivi e ritrovi culturali.” “Finalmente,” quindi, “posso presenziare e cancellare per sempre la mia Fomo.”
Così credevo, speravo. In realtà, una volta tornato in città, l’incanto della Fomo era cambiato, prendendo una piega più esistenziale e spingendomi a riesaminare alcune mie scelte del passato, immaginandone le ripercussioni sul mio presente. Dal “cosa mi sto perdendo?” sono passato al “cosa avrei potuto fare oggi se ieri avessi fatto…?”. La Fomo non era scomparsa, ma si era adeguata al nuovo ambiente, perché la Fomo è soprattutto la paura di non avere il controllo della situazione, di essere tradito dal destino, di perdersi qualcosa di strepitoso mentre avviene alle proprie spalle. Ansia sociale, insicurezza e competizione sono conseguenze e cause della Fomo, in un morboso ciclo continuo.
Quella della Fomo non è una storia lunga. Nonostante sia un sentimento in parte innato nell’essere umano — con quella sua ossessione per il meglio, il di più — una sigla simile non poteva che diffondersi in un mondo come il nostro: iperconnesso, iperveloce, ipercompetitivo, ansiogeno. Il primo a usare la sigla fu Patrick J. McGinnis, scrittore e venture capitalist che su questa parola e su questo tema è riuscito a costruire un piccolo business fatto di libri e convention. Tutto ha inizio nel 2004, quando, mentre era iscritto alla Harvard Business School, scrisse un articolo per The Harbus, il magazine della facoltà, in cui raccontava quanto fosse snervante frequentare quella scuola, a causa delle sue insicurezze personali e soprattutto del clima di folle competizione che vi si respirava.
Un habitat perfetto per due mostri: la Fomo, appunto, e la sua sorella Fobo (“Fear of a Better Option”, la paura di un’opzione migliore, di aver fatto la strada sbagliata o comunque “imperfetta”). Dalle pagine del giornale, la sigla si diffuse velocemente come un termine quasi essenziale nella società odierna, il genere di neologismo che va a riempire un vuoto semantico prima di allora poco esplorato. A favorirne il successo contribuì l’imprenditrice Caterina Fake con un post pubblicato nel suo blog nel 2011, in cui parlò di questo particolare fenomeno:
La Fomo è una grande forza motivatrice del comportamento umano, che credo giochi un ruolo cruciale nella comprensione del software sociale. In molti hanno studiato i meccanismi di gioco che spingono le persone a collezionare cose (punti, trofei, check-in, titoli di studio, kudos). Altri hanno studiato come la neurochimica che ci spinge a controllare Facebook ogni cinque minuti sia simile a quella alla base delle dipendenze. I social media ci hanno reso più consci delle cose che ci perdiamo. Sei a casa da solo ma stai guardando gli aggiornamenti di status dei tuoi amici sulla festa grandiosa che sta succedendo da qualche parte. Non sei mai stato al corrente di così tanti party.
Un fenomeno senz’altro aggravato dai social media, in cui l’utente è normalmente spinto a condividere solo alcuni momenti, quelli migliori, creando feed poco realistici in cui tutti sembrano in vacanza (tranne te), ricchi (tranne te) e meravigliosi (tranne te). È su questa rincorsa allo status sociale, un coniglio dorato inseguito da branchi di famelici cani, che si basa il successo di molti influencer: yacht, piatti sfarzosi, spiagge assolate, orologi di lusso, fisici scolpiti. Lo schermo ci tartassa di domande: “E voi che fate?”. “Dov’eravate mentre questo tizio assumeva questa posa favolosa?” E così via. Di questo passo, ritrovarsi su un’isola deserta ospiti di Ja Rule non è impossibile.
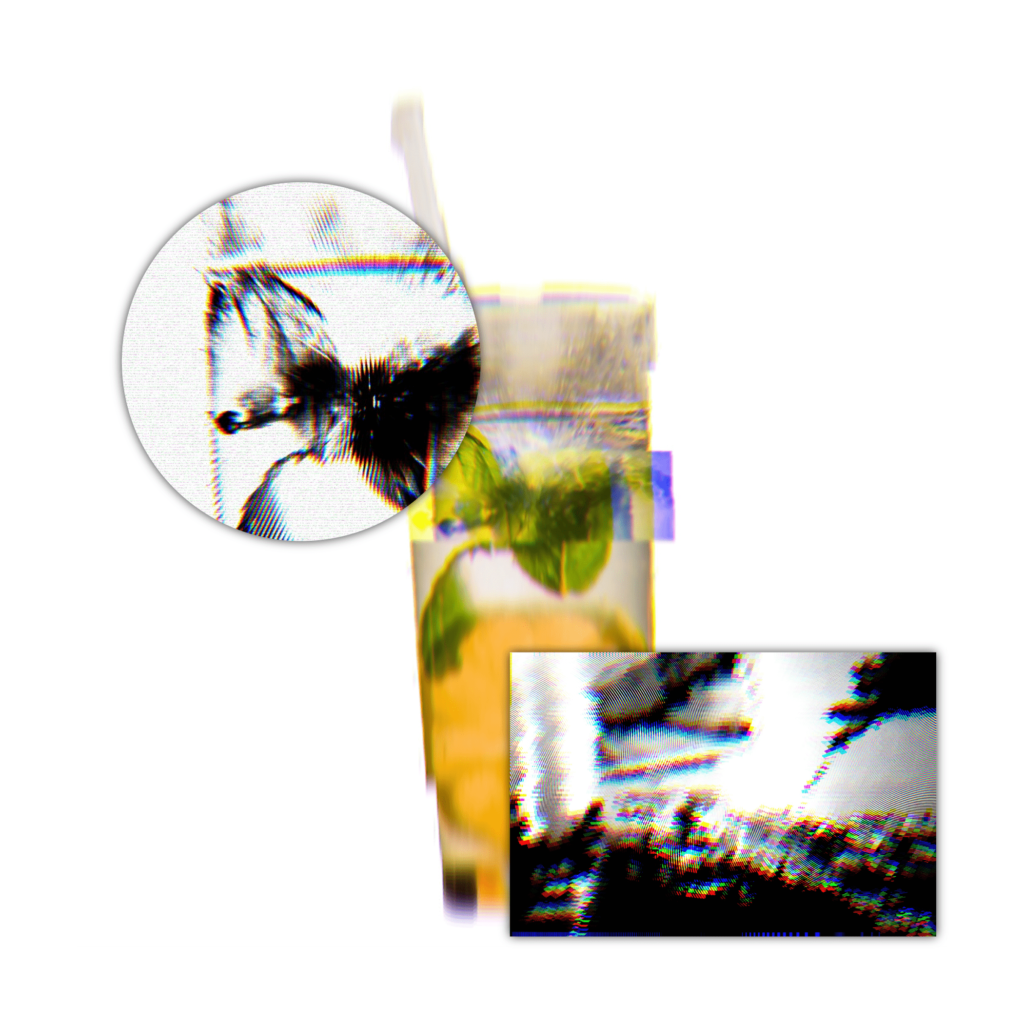
L’alchimia tra hype e Fomo è il mattone fondamentale del business dell’attenzione, la grande corsa all’oro di questi anni: siamo tutti emittenti, produttori, attori e pubblico, quindi è necessario farsi sentire per poter far passare il proprio messaggio, attrarre un pubblico, fare profitto. Chi riesce a miscelare con sapienza questi due elementi, hype e Fomo, tende a costruire
imperi, come dimostrano le code notturne davanti agli Apple Store, fatte di clienti che non possono aspettare qualche giorno in più per il nuovo iPhone.
L’alchimia tra hype e Fomo è il mattone fondamentale del business dell’attenzione, la grande corsa all’oro di questi anni.
La Fomo non viene alimentata solo da gesti costosi e assurdi come un festival di lusso in un’isola remota, ma è anzi una costante delle nostre vite, uno dei fattori che più ci spingono a passare tempo online e a consultare i social network o YouTube: in un mondo in cui tutto succede continuamente, la paura di perdersi qualcosa in qualsiasi momento finisce per essere legittima. Uno studio pubblicato nel 2018 dal Journal of Social and Clinical Psychology ha dimostrato che limitare l’accesso a Facebook e alle altre piattaforme comporta “cali consistenti di solitudine e depressione nell’arco di tre settimane”, liberandoci dalle grinfie di questo pronipote di Keteb, il demone meridiano.
L’esperimento alla base della ricerca prevedeva la divisione di 143 studenti dell’University of Pennsylvania in due gruppi: al primo veniva imposto un limite di dieci minuti all’utilizzo di Facebook, Instagram e Snapchat, mentre il secondo fungeva da controllo, con qualche ora di tempo a disposizione. Secondo i risultati dello studio, il primo gruppo “ha mostrato riduzioni della depressione e della solitudine nel corso delle tre settimane successive”. E non è tutto: “Entrambi i gruppi hanno mostrato cali significativi di ansia e di Fomo rispetto alla media tradizionale”, come se il semplice fatto di essere consci del proprio utilizzo dei social, per via dell’esperimento, avesse un effetto tangibile.
Ci risiamo quindi: basta con questo smartphone, viviamo felici! Fosse così semplice, però, il problema non meriterebbe studi approfonditi. Anche per questo Anil Dash, scrittore e imprenditore del ramo tecnologico, ha proposto nel 2012 un nuovo acronimo con cui affrontare la famigerata Fomo: Jomo. Ovvero, “Joy of Missing Out”, la ‘gioia di perdersi qualcosa’. Alle volte, non vai a quell’incredibile evento perché hai semplicemente voglia di stare a casa e leggere un libro o guardare la tv o maneggiare pigramente il tuo telefono, finché non ti rendi conto che è troppo tardi per andarci. E quindi, quando diventi vecchio e meravigliosamente, felicemente noioso come me, te ne stai a casa perché preferisci fare il bagnetto a tuo figlio e metterlo a nanna piuttosto che, beh, essere in qualunque altra parte del mondo. Questa è la Joy of Missing Out.
La Jomo è una reazione, un atto di ribellione felice. Ma è solo il primo passo verso una ridefinizione delle nostre priorità, la comprensione di ciò che è davvero importante e cosa invece esiste per tentarci, distrarci, metterci ansia. Pensate a tutti quegli eventi strombazzatissimi che avete atteso con ansia riuscendo ad andarci, finendo poi per andarvene dopo poco o rimanere senza divertirvi granché. Tutte le Situazioni Imperdibili di cui conservate pochi ricordi sbiaditi. Scegliete un evento passato e confrontatelo con le relative foto pubblicate sui social; poi, misurate lo scarto tra la vostra realtà e l’hype di quelle immagini. È in quel gap, quella bolla d’aria e di aspettative, che si sviluppa la Fomo. È un’attività mentale da fare giorno dopo giorno, per costruirsi nel tempo una pelle più resistente al canto di questa sirena.
È possibile distruggere la Fomo, per sempre? No, ovviamente. Questa forma d’ansia sociale si rigenera, senza mai estinguersi. Ma può essere scalfita, ridotta a una vocina nella vostra mente a cui dare sempre meno ascolto.
A quel punto, cosa succede alla Fomo? Diventa forse Jomo? A mio avviso, no. Lo stadio finale di questo progetto, quello della vittoria del senno sulle facili tentazioni, non è né la paura né la gioia, ma un’altra cosa, per cui coniamo l’acronimo Nomo, “Noncuranza of Missing Out”.
Pensare a quello che vi state “perdendo” e fregarvene, facendo scivolare quell’assillo come l’acqua di un fiume su un ciottolo liscio. Sarete oltre, all’asciutto, ad ammirare da lontano i disperati falò di tutti i Fyre Fest del mondo.
Questo testo è estratto dal primo libro di Pietro Minto, Come Annoiarsi Meglio (Blackie Edizioni, 2021).


