Lingua di giorno, lingua di notte
Eresie del desiderio nella traduzione di Olga Tokarczuk.
La prima volta che incontrai dal vivo Olga Tokarczuk fu in una terra di nessuno, un non-luogo all’interno di un non-luogo, una piccola hall di un piccolo albergo di una provincia del Nordest dimenticata dal mondo. È una piccola, intraducibile storia di interstizi e di spazi di confine, un gioco di scatole cinesi dove al caos di una parlante straniera si era aggiunta l’emozione di un incontro importante – un incontro che non ebbe davvero luogo.
Mi presentarono invece suo marito, con cui cercai di scambiare due parole, ma il mio polacco incespicava e si ritraeva, diventava uno scalpiccio trafelato e indistinto di parole accartocciate che raffazzonavo da dietro la mascherina; lui non parlava inglese, e la nostra divenne presto una piccola e goffa conversazione intraducibile fatta di sguardi e intenzioni, dove la comunicazione avveniva soltanto tramite gli occhi e la buona volontà di comprendersi. Quella sera Tokarczuk tenne un discorso di accettazione di un premio, e il suo ringraziamento andò innanzitutto ai traduttori, che “con le loro arti simili ad Hermes sono in grado di trasportare una lingua in un’altra lingua e un concetto in un altro concetto”.
Nelle parole c’è sempre uno scarto, la mancata corrispondenza tra significante e significato e che in ogni sistema di segni differisce per estensione e gravità.
Tradurre, insomma, che nella lingua madre di Tokarczuk è tłumaczyć, con l’accezione di chiarimento, spiegazione – ma anche przekładać, che ricalca l’immagine di spostamento da un luogo all’altro della translatio latina. Parole fatte di storie, di viaggi e di spazio. Eppure anche nelle parole c’è sempre uno scarto, un’infinita possibilità che nasce da una condanna, la mancata corrispondenza tra significante e significato e che in ogni sistema di segni differisce per estensione e gravità. E oltre le parole l’ineffabile del desiderio e dell’immaginazione, della creazione come tradimento del possibile, della mancata rassegnazione alle leggi della lingua e della realtà.
Ma come tradurre e tradire quest’ineffabile, come si creano miracoli da una realtà fatta di asimmetrie? “È quell’indistinto spazio nero tra un giorno e l’altro il vero viaggio”, scrive in Casa di giorno, casa di notte. Resta da capire cosa farne, allora, dell’intraducibile, di quell’indistinto spazio nero, e come trasportarlo da un giorno all’altro, da una lingua all’altra, da una lingua di giorno a una lingua di notte.
Tra tutti i romanzi di Tokarczuk Casa di giorno, casa di notte è l’opera che più di tutte affronta il tema del genere, della fluidità e della (meta)narrazione al di fuori del binarismo, servendosi del linguaggio per sovvertire il regime discorsivo entro cui si muovono l’autrice, i suoi personaggi e l’economia dei loro desideri. Se prendiamo anche la lingua come un indistinto spazio nero, possiamo affacciarci sulle possibilità creative dell’indeterminato, di ciò che sfugge, dei piccoli fantasmi dimorati negli interstizi della notte.
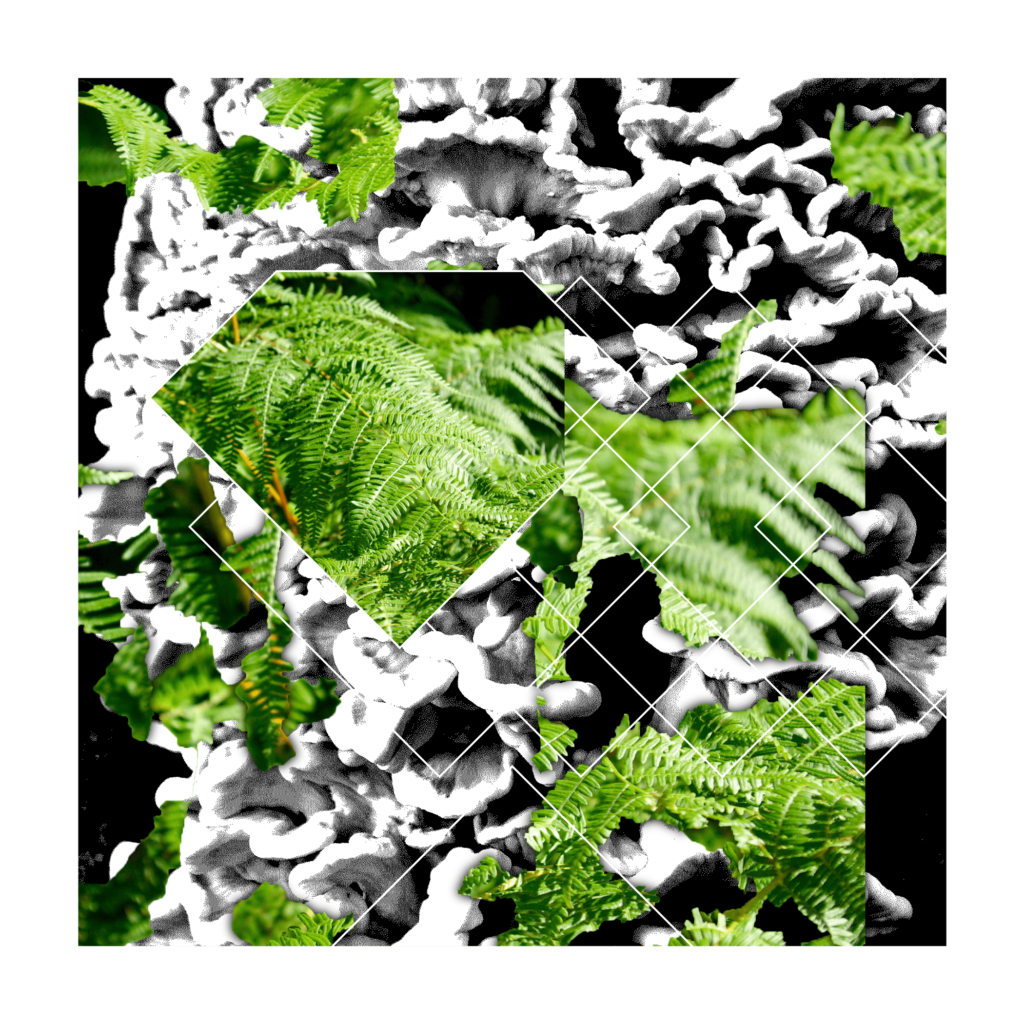
Tokarczuk parla infatti dei suoi romanzi come di “costellazioni” di brani sparuti e affreschi frammentari che il lettore impara a riconoscere e interpretare arbitrariamente come dei segni senzienti in cielo, ma la fisica ci insegna che, a suo modo, anche la luce che vediamo oggi è in un certo senso spostata, traslata: tradotta. L’operazione del traduttore-astronomo si fa allora infinitamente più delicata, se a cambiare nel corso della traduzione sono le stesse coordinate celesti: e se anche la parola “desiderio” rientra nel campo semantico dell’osservazione astronomica, il lessico di questa lingua di notte deve tenere conto della differenza tra queste strane geometrie astrali.
Ma procediamo con ordine, partendo proprio dalla sua mancanza. Casa di giorno, casa di notte è infatti un’opera la cui struttura non è ascrivibile a una trama definita: è un testo che mira a evocare atmosfere, destare impressioni, creare mondi. Nella prima parte della produzione letteraria di Tokarczuk si riscontra una tendenza al misticismo e al reincantamento della sua Polonia rurale, un tentativo di creare una mitologia di uno spazio di confine che fuori dal territorio della narrazione sarebbe stato dimenticato.
Ma se Nella quiete del tempo era un lavoro di memoria, Casa di giorno, casa di notte è un lavoro di immaginazione ex nihilo, che si snoda tra racconti di sogni, ricette e agiografie in un intreccio di mondi che sorge in quell’indistinto spazio nero oltre le dicotomie frapposte tra un giorno e l’altro, tra uomo e donna, tra corpo e anima, tra lingua e realtà. Obiettivo dell’autrice è quello di piegare il linguaggio all’utopia dimostrando le potenzialità creatrici del desiderio, uniche in grado di superare la massima di Wittgenstein secondo cui “i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”.
Da un punto di vista strettamente formale e linguistico, la prima operazione messa in atto da Tokarczuk è la riflessione sul genere e sulla matrice patriarcale dei suoi ingranaggi semiotici. Nonostante il polacco abbia anche un genere neutro, a differenziarla dalle altre lingue del ceppo slavo è l’insistenza sul concetto di “maschile personale” che cambia le modalità di declinazione, a sancire il primato della razionalità umana anche nel registro simbolico della parola. Per sfuggire a questo meccanismo il lessico di Tokarczuk si serve di vocaboli femminili, di sovversioni pragmatiche e di neologismi che riequilibrano e suggeriscono, almeno sul piano immaginario, la possibilità di creare mondi e soggettività dalle macerie di una mancanza.
Il lessico di Tokarczuk si serve di vocaboli femminili, di sovversioni pragmatiche e di neologismi che riequilibrano e suggeriscono la possibilità di creare mondi e soggettività dalle macerie di una mancanza
Si ha innanzitutto l’insistenza su termini astratti, generalmente di genere femminile, così come un utilizzo cospicuo di nomi di piante, associate spesso alla femminilità e alla donna – si pensi all’accostamento hegeliano, sovvertito dall’autrice nei numerosi capitoli che raccontano microcosmi partendo non più dal corpo umano, bensì dalla verdicante, eterna vita delle piante. La narrazione e la misurazione del tempo vengono strappate al monopolio dell’uomo, non più misura di tutte le cose, e vengono ricontestualizzate a partire dalla terra e dagli elementi del paesaggio. Nella sua analisi letteraria e lessicografica del romanzo, Urszula Paleczek nota come “lo stesso utilizzo del linguaggio giochi un ruolo estremamente importante nell’opera di Tokarczuk – lo “piega” per illustrare le esperienze specificamente femminili dei suoi soggetti. Il suo linguaggio mette in discussione le categorie convenzionali del patriarcato e crea uno spazio linguistico dove diventa possibile raccontare la storia dell’Altro”, in cui l’Altro sono i soggetti obliqui, marginali, nomadi.
Non a caso uno dei neologismi più interessanti all’interno del romanzo è il sostantivo femminile grzybość, letteralmente “funginità”, che nella traduzione inglese viene resa con il sintagma “on being a mushroom”, in quella in italiano “essere un fungo”, perdendo così la connotazione di genere – anche nel caso di una condizione che definiremmo neutra per l’accostamento ai funghi – in entrambe le lingue. Il capitolo sulla grzybość è un’interessante riflessione sulla consistenza del corpo e del testo, dove il corpo viene inscritto sulla superficie delle parole per dare forma a un entità sfuggente, un soggetto straripante ed erratico (“Sarei effimera, ma lo sono anche come essere umano”; “Sarei generosa con tutti i parassiti; donerei il mio corpo a lumache, larve e altri insetti. Non nutrirei alcun timore”), che come i funghi è in grado di crescere “su ciò che è morto” e che in virtù della sua ineffabilità è in grado di instillare confusione nelle menti irresolute degli uomini fuori dalla storia della ragione. Aggirando infatti le norme dell’economia libidinale di scrittura, passioni e legge, Tokarczuk inserisce all’interno del romanzo una serie di ricette dove vengono impiegati funghi velenosi per operare ancora una volta una riflessione sui confini e sui limiti del binarismo, applicato stavolta a una delle dicotomie che diamo più per scontate, quella vita-morte.
“Come se mangiare o non mangiare qualcosa potesse salvarci dalla morte. Si muore indipendentemente dal fatto che si mangi questo o quello. […] Mangiando la carcateppa dunque si rimane per un momento in bilico tra la vita e la morte. Per una certa percentuale si è vivi, per una certa percentuale morti. Difficile dire quando una cosa si trasformi nell’altra. Chissà perché la gente attribuisce tanto peso all’unico, breve istante dell’aut aut”.
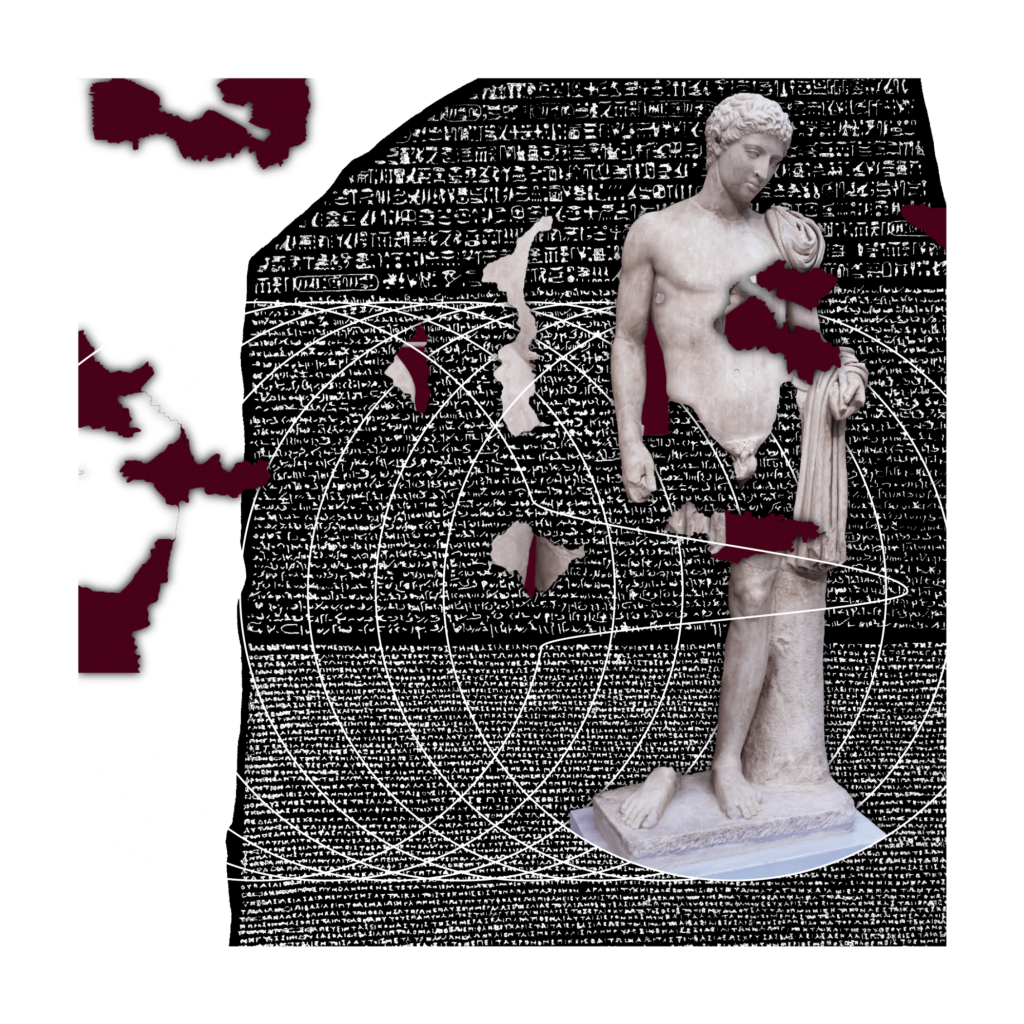
L’istanza più interessante nell’ambito della traduzione comparata è tuttavia il curioso caso di un’omissione dalla traduzione inglese, rilevata sempre da Paleczek. Nella traduzione di Antonia Lloyd-Jones mancano infatti due frammenti: uno per intero, Listy, in italiano Lettere, dove Tokarczuk muove dai cortocircuiti patriarcali del polacco corrente per ravvisare alcune peculiarità del linguaggio genericamente connotato; l’altro è invece la conclusione de Il fuoco, che termina la riflessione iniziata nel paragrafo citato. In Lettere, infatti, la voce narrante postula un’“universale femminilità” del mondo, interrotta da “parole sicuramente ingiuste, […] nate da un mondo diviso in maniera ineguale e sciatta”. “Qual è”, si chiede, “l’equivalente femminile della parola “virilità”? “Donnità”? Come definire questa qualità in una donna senza cancellarne il sesso?”. Vale la pena menzionare che nell’originale entrambi i vocaboli utilizzati da Tokarczuk (il termine corrente męstwo e il neologismo da lei creato żeństwo, reso in traduzione italiana come donnità) sono di genere neutro.
Il paragrafo continua con una meditazione sull’inesistenza di un termine per designare la saggezza femminile, incarnata nel libro dallo sfuggente personaggio di Marta. Se infatti il polacco ha starec e mędrzec, tradotti da Raffaella Belletti come “vecchio” e “saggio”, l’equivalente femminile diventa staruszka o starucha, entrambi diminutivi di stara, vecchia, che in italiano diventano “una vecchia o una vecchietta, come se nell’invecchiarsi delle donne non ci fosse nessuna dignità”. Tokarczuk suggerisce poi che “al massimo si può definirla wiedźma, “strega”, e rimarcare che il termine deriva dal verbo wiedzieć, “sapere””.
Paleczek afferma che l’operazione di Tokarczuk non poggi su prove etimologiche, ma le ricerche sull’antico slavo orientale, evoluzione del protoslavo parlata nell’allora territorio della Rus’ di Kiev, sembrano invece confermare la connessione tra i due termini. La digressione linguistica dell’autrice si esaurisce nel già menzionato explicit de Il fuoco, dove la protagonista giunge alla conclusione che “l’equivalente femminile della parola ‘saggio’ è ‘saputa’.”. Anche qui viene perso un tassello, dal momento che il termine originale polacco mądrala, seppure femminile nell’aspetto grammaticale, è utilizzato nella lingua corrente sia per gli uomini che per le donne, come osservato da Paleczek.
“Non credo di aver detto qualcosa di veramente importante in vita mia. Per le cose più importanti mancano comunque le parole.”
Le problematiche sollevate da queste prime scelte stilistiche vengono infine sublimate nella sezione più peculiare del romanzo: l’agiografia della santa barbuta Kummernis, con corpo di donna e volto di Cristo, a opera di Paschalis, monaco che nella stesura della vita della santa dà voce al proprio desiderio di voler vivere come donna. L’espressione di genere di Kummernis e Paschalis si colloca anch’essa al di là delle logiche binarie, e si qualifica come una vera e propria sfida all’istituzione. Nella sua monografia critica dedicata a Tokarczuk, Katarzyna Kantner nota come nello stesso impianto narrativo del romanzo “il testo viene considerato eretico, perché non rientra nei confini del discorso dominante. La scena dell’udienza con il vescovo è esplicativa del rapporto tra il linguaggio dell’autorità, dell’ortodossia cattolica, e tutto ciò che non si confà all’ordine da esso descritto”.
Viene allora spontaneo tornare all’écriture féminine di Cixous e alla necessità di scrivere partendo dall’ordine libidinale del corpo desiderante, eppure ritengo che per ripensare lo spaesamento si debba partire dal concetto di eresia per come lo formulò Kristeva, come potenza latente di una scrittura che ecceda il Senso e la Legge ripartendo dalla rappresentazione di un corpo e di un desiderio rimasti fino ad allora insignificanti e insignificabili. Nella decostruzione della sacralità del testo agiografico di Paschalis, Tokarczuk sceglie l’apologia del fluido, dell’imprevisto e dell’irriducibile per gettar luce sulla complessa dialettica tra scrittura e godimento, che rende manifesta la tensione tra convenzione e invenzione, narrazione e autocreazione. Nelle antinomie del desiderio di Kummernis e Paschalis, Kantner riconosce “il raggiungimento dei limiti del linguaggio, l’inutilità delle categorie e dei predicati, […] il gioco di paradossi e contraddizioni che rendono la divinità impossibile da esprimere attraverso rigide forme teologiche”.
Se tuttavia l’anonima voce narrante di Casa di giorno, casa di notte deplora la mancanza di un lessico che renda giustizia all’ineffabile dell’esperienza femminile (“Non credo di aver detto qualcosa di veramente importante in vita mia. Per le cose più importanti mancano comunque le parole.”), l’impianto del testo, nell’originale come in traduzione, fa emergere l’intraducibile del desiderio da quell’indistinto spazio nero. Alla fine del frammento La tata, una meditazione sulle possibilità di vedersi altrimenti attraverso la lingua dell’Altro, la rassegnazione per la mancanza di parole fa spazio alla speranza implicita del vero viaggio, di un senso diverso e nuovo che germoglia nella distanza:
“Quello sguardo, quel punto di osservazione al di fuori di me, sarebbe comparso sempre più spesso, finché non avrebbe cominciato a cambiarmi, perché avrei perso la certezza di chi fossi, di quale fosse il mio centro, il punto intorno al quale si disponeva tutto il resto. Avrei visto le stesse cose di volta in volta in maniera diversa. […] L’unico vantaggio che ne deriva è che i mondi visti da punti diversi sono mondi diversi. Dunque posso vivere in tanti mondi quanti sono in grado di vederne”.


