Annebbiato dal Warscrolling
Guardare la guerra “succedere” su Instagram mi ha ricordato come la competizione per l’attenzione non sia un bug ma una feature delle piattaforme social.
Nei giorni che hanno preceduto l’inizio dell’invasione russa in Ucraina non ho guardato molto la BBC, né il suo sito, né i suoi social, né i suoi canali tv.
Qui a Londra la pandemia è stata decretata come ufficialmente “conclusa” da Downing Street e questo ha, nelle ultime settimane, inevitabilmente rallentato la mia attenzione nei confronti delle news: meno doomscrolling, meno accelerazione, meno FOMO, meno Twitter implementato sulla retina.
Non che condivida le mosse di Boris Johnson, non che questa attitudine più rilassata nei confronti della COVID-19 sia necessariamente corretta, ma, pur restando un news junkie patologico, il punto di saturazione nei confronti dell’attenzione spasmodica alle notizie assunta negli ultimi due anni, per me, era arrivato in qualche momento imprecisato della seconda metà di febbraio.
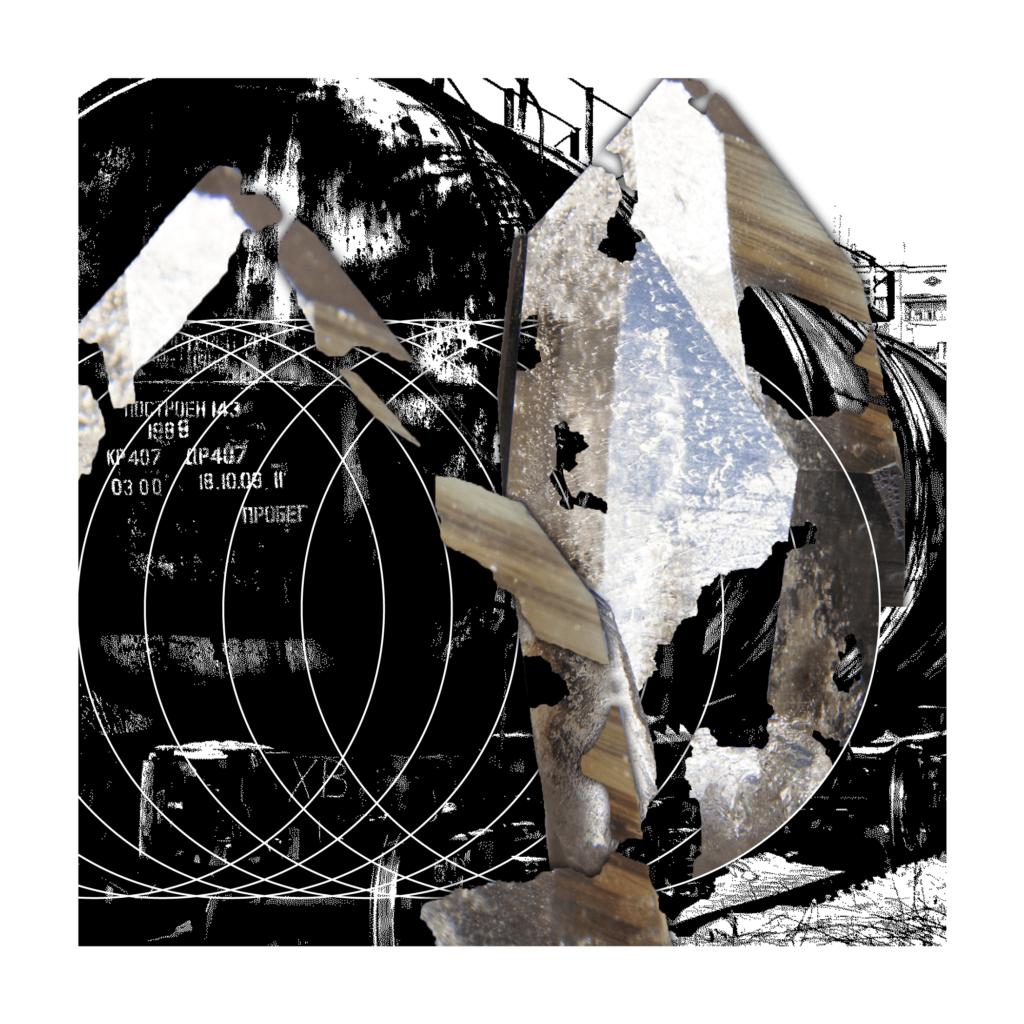
Attorno a quel periodo, si può dire, mi ero quasi talmente allontanato dall’abitudine di cercare e leggere costantemente le notizie, o mi ero anche io in primis arreso (per fortuna?) a quello che Bifo ha chiamato il collasso psichico del contemporaneo. Arreso, sconfitto. A tal punto che, una mattina molto presto, pur dovendo volare in Italia, mi ero persino svegliato per andare in aeroporto senza prima guardare le news, né Twitter, né nulla se non Citymapper.
Sta di fatto che, uscito di casa per andare a prendere il treno per Gatwick, sono arrivato in stazione completamente all’oscuro del fatto che in buona parte del Regno Unito – Londra compresa – fosse stata diramata un’allerta meteo emergenziale per quella che era stata annunciata – a insaputa mia e del mio collasso psichico – la peggiore tempesta dei precedenti trent’anni, la Storm Eunice. C’era stato, apparentemente, anche un appello da parte del sindaco di Londra, Sadiq Khan, a restare in casa, a evitare i mezzi pubblici. Di conseguenza, ero anche quasi completamente all’oscuro del collasso dei mezzi pubblici di Londra, chiusi in via precauzionale per via del forte vento.
Sta di fatto che arrivare a Gatwick quella mattina è stato molto più complesso del solito e la ragione mi è stata chiara solo quando ho finalmente aperto l’app della BBC, fino a quel momento accuratamente silenziata per non ricevere più notifiche push. In aeroporto ho anche incontrato un amico, anche lui in partenza ma, contrariamente a me, per un paese confinante con la Russia.
Prima di salutarci per andare ai rispettivi gate, ricordo che abbiamo scambiato qualche parola sull’allora teso clima diplomatico tra Mosca e Kyiv, chiedendoci cosa sarebbe potuto succedere da lì a qualche giorno. Credo sia stata la mia ultima discussione sulla possibilità di una guerra, prima che la guerra esplodesse per davvero e con un’escalation così devastante. Da quando l’invasione russa è diventata tale, aprendo la strada a una invasione criminale, indecente e brutale, la BBC, in tutte le sue possibilità di fruizione, è diventato il mio canale di accesso principale all’informazione, con buona pace del collasso psichico cui pensavo di essermi arreso, ma che era evidentemente ancora posticipabile.
Dal punto di vista del giornalismo e dell’informazione, dopo due anni di pandemia non poteva accadere nulla di peggiore di questa aggressione militare. Ma la guerra è invece purtroppo arrivata e, in questo contesto di esasperazione, panico e complessità, tradurla in termini giornalistici, anche dal punto di vista di chi, come me, è abituato a seguire il flusso delle notizie per lavoro, mi sembra sempre più difficile.
Si potrebbero fare – e si stanno facendo come sempre – numerose considerazioni su come i media contemporanei stiano raccontando questo conflitto e su come, generalizzando, il sistema mediatico dentro cui ci troviamo, stia rispondendo all’invasione russa dell’Ucraina. A me, però, in estrema sintesi e in quella che potrebbe sembrare una resa intellettuale, tutto questo appare sempre più intraducibile, specialmente se lo guardo togliendomi la lente di osservazione da addetto ai lavori.
L’assalto russo dell’Ucraina arriva dopo quasi quindici anni di discussione estenuante sull’impatto dei social sull’informazione e dopo ormai quasi sei anni di dibattito delirante sulle sʍǝu ǝʞɐɟ, la disinformazione e la weaponization delle piattaforme. E, bene ricordarlo, dopo due anni di pandemia che hanno devastato le già traballanti fondamenta del sistema-giornalismo in tutto il mondo. Se serviva rallentare, prendere fiato, ricostruire, guarire e reinventare, le bombe su Kyiv hanno rimesso tutto ulteriormente in discussione, colpendo inoltre il sistema dove fa più male.
Il dibattito attorno al giornalismo in questi contesti tende di norma a impantanarsi presto tra chi rivendica un decadente primato del “Giornalismo” (inteso di norma nel modo più conservatore possibile) nel saper raccontare la realtà e chi, dall’altro, sbraita della certa superiorità della “Rete” (intesa invece nel modo più generico e casaleggiàno possibile) a fare lo stesso.
Soprattutto in Italia, la prima posizione è di solito assunta in forma difensiva e senza apparenti meriti giornalistici o etici, mentre la seconda è ormai il primo passo verso il grande mare aperto del complottismo destrorso o rossobruno o del misticismo tecnologico dei “nuovi media”, ma con due decenni di ritardo.
I punti di vista ancorati alla realtà – basati ad esempio sulla consapevolezza che il “Giornalismo” e la “Rete” non siano necessariamente due sistemi in conflitto tra di loro – difficilmente trovano spazio in questa polarizzazione, facendo perdere sistematicamente a questi dibattiti l’occasione di avere un impatto positivo o, quantomeno, di essere al passo coi tempi.
L’aggressione russa dell’ucraina, come tutti gli eventi di così grande portata, è però un prisma interessante attraverso il quale osservare questi cambiamenti nella sfera dell’informazione e il modo in cui, inevitabilmente, ci rappresentano la realtà in cui avvengono. La differenza rispetto ad altri eventi simili, credo, è però data dal fatto che l’invasione dell’Ucraina stia avvenendo ancora dentro il contesto della pandemia e a pochi mesi di distanza dalla caduta di Kabul, un altro evento particolarmente significativo dal punto di vista mediatico. Mentre, sullo sfondo, aleggia sempre il collasso psichico.
Guardare attraverso questo prisma, che ci fa vedere quella che senza dubbio è una delle guerre più “visibili” di sempre, l’immagine che emerge è, però, a me sinceramente indecifrabile. Generalizzare è sempre sbagliato e miope, ma la sensazione è che l’invasione dell’Ucraina abbia messo da parte alcuni degli assunti che reputiamo per assodati sugli assetti dell’informazione contemporanea e sulla sua cultura. Credo sia complice l’esasperazione da pandemia, ma raramente ho cercato maggior rifugio in quello che – erroneamente – qualcuno definirebbe il “Giornalismo”: tutta la mia comprensione degli eventi ucraini mi è arrivata dalla BBC o dai giornali di carta.
Mi sono volutamente rifugiato in un modo di informarmi che funzionasse da sé, che mi arrivasse già pronto e in modo forse rassicurante. Ci sono state diverse analisi su come Instagram o addirittura TikTok abbiano finalmente trovato i loro spazi come piattaforme giornalistiche forse prioritarie per il racconto di questo conflitto: a me, al contrario, sembra solo il grande ritorno della televisione e delle sue dinamiche, quella stessa televisione contro la quale si era scagliata tutta la retorica rivoluzionaria del digitale.
Sembra legittimo chiedersi: la rivoluzione digitale – ammesso che sia esistita, come si chiede lo storico dei media Gabriele Balbi – è servita a riportarci allo zapping delle immagini cruente di un conflitto bellico intervallate dai video delle vacanze ogni dieci secondi?
Mi preme però puntualizzare una cosa: non credo assolutamente nella retorica del “Giornalismo” (né in quella della “Rete”) e al suo presunto primato. Al contrario, credo che esistano i giornalismi e oggi che questi siano il quanto più ibridati possibile con cose che stanno, almeno in linea di principio, fuori dal giornalismo, ma che entrano a farvi parte, più che legittimamente.
Credo questo approccio sia perfettamente rappresentato dall’impagabile lavoro, fatto proprio sui social e con i social, di una testata come Bellingcat, che ha saputo come nessun’altra cogliere le migliori potenzialità che i social media potevano offrire all’avanzamento del giornalismo.
Quella della open source investigation è forse la strategia di racconto più interessante emersa negli ultimi anni, e proprio in Ucraina sta mostrando ancora una volta quanto sia fondamentale il lavoro di reporting e verifica che può essere fatto in questo modo. Proprio perché non credo nella distinzione tra “Giornalismo” e “Rete”, credo ancora che i social abbiano cambiato complessivamente i giornalismi in meglio, rendendoli più complessi, più aperti, più completi, dando loro più voci.
Nei momenti di massima tensione, come queste settimane di guerra, alle volte tutto questo può però diventare anche intraducibile. È il prezzo della complessità, sicuramente, ma forse con Bucha siamo arrivati a un punto estremo di saturazione, di fatica, di collasso. Quello che, appunto, mi ha spinto – più che mai – a rivolgermi alla BBC in queste settimane e al suo lavoro impeccabile di sintesi, di raffreddamento e di rallentamento. Il più classico e antico lavoro giornalistico, si potrebbe dire.

Non so di preciso cosa ci sia all’origine di questa sensazione di resa. Sicuramente l’eccesso di orrore continuo, forse il peso di due anni di tragedia e conta dei morti, forse il senso di panico perenne imposto dalla pandemia e ora dalla guerra, ma mai più che dal 24 febbraio “vedere” la guerra ri-postata sui social media mi ha dato un senso di repulsione, di distanza dal reale, di spaesamento, di fuga da quello che mi sembra un rituale in tutto e per tutto “da social” e non di informazione.
Vedere apparire la guerra a tradimento nelle Stories di Instagram, in particolare, affiancata al posizionamento strategico degli influencer, ai brand che monetizzano l’indignazione, ai giornalisti che timbrano il cartellino sul fatto del giorno o peggio sulla polemica di giornata, mi sembra abbia amplificato un senso ancora più forte di assurdo e di intraducibilità.
Ed è specialmente quando mi tolgo le lenti di addetto ai lavori e guardo questo flusso non sbrogliabile di piani sovrapposti, di codici e di linguaggi che si mischiano nell’economia dell’attenzione che le possibilità di traduzione efficace degli eventi mi sembra un miraggio: solo i giornalisti o chi lavora attorno al giornalismo guarda quel flusso con la volontà di decifrarlo e di tradurlo. Chiunque altro, e più che legittimamente, lo guarda nella speranza che le o gli dica qualcosa da sé e senza doversi impegnare in un lavoro di decifrazione e traduzione di tutti i piani sovrapposti e dei loro incastri.
Guardare la guerra “succedere” su Instagram mi ha ricordato come il doomscrolling sia non un bug ma una feature di come funzionano le piattaforme, la loro economia e la loro politica in circostanze estreme, quando vengono messe sotto pressione da eventi enormi e tragici. Non credo assolutamente che le piattaforme vadano abbandonate, né che ci rendano stupidi, né che siano la fine della democrazia, né che sarà il “Giornalismo” a raccontarci la realtà nel migliore dei modi possibili, al posto loro.
Ma c’è, almeno per me, un’inedita sensazione di brain fog, di sbrocco, di alienazione che emerge da quel flusso intraducibile di messaggi. Non le so ancora dare un nome, ma forse è la rappresentazione perfetta e precisa del collasso in cui è toccato vivere. Per me, paradossalmente, tutto questo ha la voce di Clive Myrie, uno dei corrispondenti che la BBC ha mandato in Ucraina noto, anche, per essere il volto del quiz show Mastermind su BBC Two.


