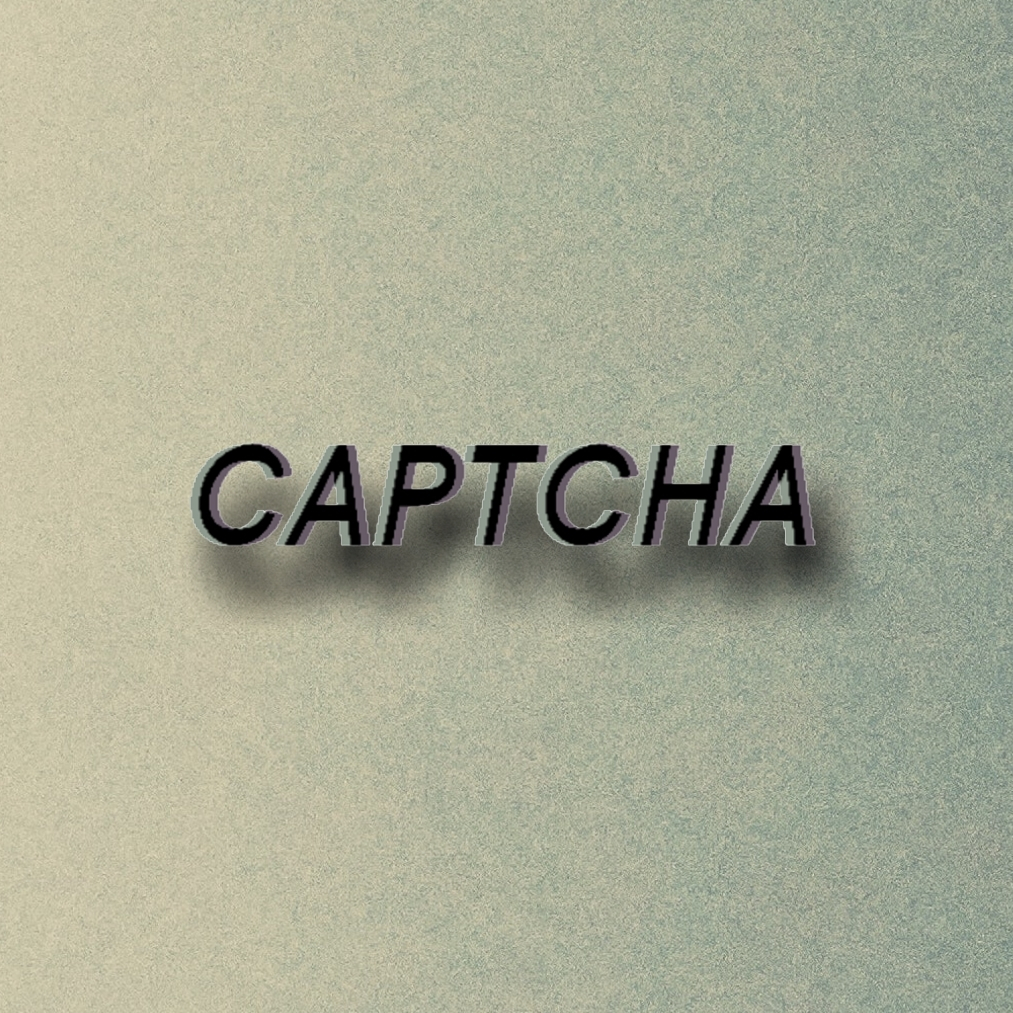Alle periferie della logistica
La pandemia ha svelato chi siano i veri lavoratori essenziali, portando alla luce il fragile legame tra logistica e periferie.

Dopo il 1989, i Paesi dell’ex Unione Sovietica si trovarono davanti a una frattura epocale nella loro organizzazione politica ed economica: con il passaggio dal socialismo al capitalismo, nazioni come la Polonia e la Repubblica Ceca vennero catapultate in un mercato globale che si muoveva a grandi passi verso il neoliberalismo post-fordista. Un sistema aggressivo in cui le grandi compagnie prendevano il posto degli stati-nazione: dall’URSS ad Amazon.
Negli ultimi dieci anni, Amazon si è espansa nel mercato europeo con grande ferocia. Anche se il suo sbarco nel Vecchio Continente risale al 1998, quando iniziò a fornire il suo servizio e-commerce a Gran Bretagna e Germania, la vera occupazione neoliberale del suolo europeo è cominciata con gli anni dieci. Ad oggi, Amazon opera in più di 40 paesi europei tramite 86 centri di distribuzione e un numero imprecisato di data center (almeno 14, secondo un documento reso pubblico nel 2015 da WikiLeaks). Nel novembre del 2019, i territori europei occupati da strutture Amazon si estendevano per più di cinque milioni di metri quadrati — senza contare gli spazi di Amazon Web Service, gli uffici e i laboratori di ricerca. Sono dati che parlano di una forma attiva di colonizzazione, in cui il colonizzatore non sta solo occupando l’Europa, ma anche modificando le abitudini di chi ci vive.
Il metodo di occupazione del suolo europeo ricalca quello applicato negli Stati Uniti: per trovare la posizione più efficiente per un nuovo centro logistico, i manager di Amazon si fanno guidare da un algoritmo che considera diversi fattori, primo fra tutti la tassazione locale. Per esempio, verrà favorita una zona o uno stato dove le tasse a carico del venditore sono basse, ma che confini con uno stato più ricco e popoloso che applica tasse ingenti solo alle aziende che vi hanno la propria sede fisica. Attraverso questo sistema di elusione fiscale, Amazon può mantenere sempre un ulteriore 10% di sconto sul prezzo, già di per sé basso, dei suoi libri. È per questo motivo che l’Everything Store ha invaso alcuni paesi dell’ex URSS con i suoi centri di distribuzione.
Pur contando rispettivamento sette e due Amazon facilities, la Polonia e la Repubblica Ceca non hanno una piattaforma nazionale Amazon Marketplace: per comprare su Amazon, un cittadino ceco o polacco deve navigare sul sito tedesco, disponibile anche in inglese, per poi ricevere un prodotto stoccato nel suo stesso paese. Questi due paesi nello specifico, come in generale tutti quelli dell’est Europa, non sono attraenti per il potere d’acquisto dei loro abitanti, molto basso rispetto a quello dei paesi dell’Europa occidentale, ma lo sono per il basso prezzo del lavoro: le tasse e i prezzi immobiliari sono più bassi, e spesso le regolamentazioni in materia di lavoro sono meno restrittive. Basti pensare che Amazon offre ai lavoratori polacchi e cechi un quarto del salario tedesco, e che la percentuale di sindacalizzazione è del 12% in Polonia e del 17% in Repubblica ceca. È significativo che nel 2019, proprio dopo l’esplosione di una protesta nazionale durante il Prime Day in Germania, Amazon abbia annunciato un cambiamento nella sua strategia di espansione, pianificando di aprire un nuovo centro di distribuzione in Polonia nei mesi successivi per assistere quei clienti tedeschi che, nonostante l’infuriare delle proteste, volevano fare acquisti sul sito. Se il Vecchio Continente è la nuova colonia di Amazon, l’Europa dell’est è il territorio periferico di supporto per i consumatori dei vicini paesi dell’Europa Occidentale.
Il benessere dei lavoratori umani e il funzionamento delle macchine non hanno mai lo stesso peso
Un altro fattore che l’algoritmo di Amazon considera per collocare i servizi logistici è la prossimità a infrastrutture preesistenti per i centri di distribuzione, e a fonti di energia a buon mercato per i data center. Per quanto remoto o inospitale possa essere il luogo scelto, il benessere dei lavoratori umani e il funzionamento delle macchine non hanno mai lo stesso peso — una logica che a volte ha condotto a casi estremi. Come quello di Dunfermline, Scozia, un centro di distribuzione collocato così lontano da qualsiasi centro abitato e così difficile da raggiungere con i trasporti pubblici che i lavoratori hanno cominciato a dormire nei paraggi in tenda o in auto, per risparmiare sui tempi e sugli alti costi dei trasporti. Come Frank Bsirske, capo del sindacato Verde che ha rappresentato i lavoratori di Amazon durante le proteste scoppiate nel 2018 in tutta Europa, ha dichiarato al quotidiano danese The Local: “Abbiamo un problema internazionale, un capo che vuole imporre condizioni di lavoro americane al mondo intero.” Ma la conquista del mondo per mano di Amazon è appena cominciata.
Sembra anzi che le ambizioni dell’azienda non si limitino solo a questo pianeta: se Jeff Bezos sta distruggendo la Terra con l’enorme impatto ambientale dei suoi business, sta anche cercando una via di fuga. Con la sua compagnia aerospaziale Blue Origins, Bezos vuole trasformare la Luna nella zona industriale della Terra, che si ridurrebbe a “zona residenziale e per la produzione leggera”. Bezos stesso ha dichiarato che “la ragione per cui dobbiamo andare nello spazio, secondo me, è salvare la Terra”. Amazon sta testando un lander lunare che diventerebbe il vettore primario di un sistema di logistica pianeta-satellite: una specie di navicella-cargo che faccia consegne sulla Luna, un Amazon Prime per cittadini lunari.
Non è distopico pensare che Amazon abbia già avviato le prime fasi del suo programma di colonizzazione lunare con alcuni esperimenti sulla Terra. Le sue strutture sono molto simili a una colonia lunare: hanno un’architettura estremamente semplice in cui i robot, controllati da sistemi informatici gestiti da remoto, prestano senza interruzione i loro servizi al genere umano. In relazione allo spazio gli uomini sono pochissimi, e fungono da guardiani dei robot — rimanendo spesso immobili e inattivi in questi luoghi inospitali. Tanto i centri di distribuzione quanto i data center sono respingenti per gli esseri umani: i primi non hanno riscaldamento a causa delle dimensioni, e sono inondati del rumore continuo delle macchine; i secondi hanno temperature insopportabili a causa dei server, che producono un rumore bianco disorientante. Sono zone “human-free”.
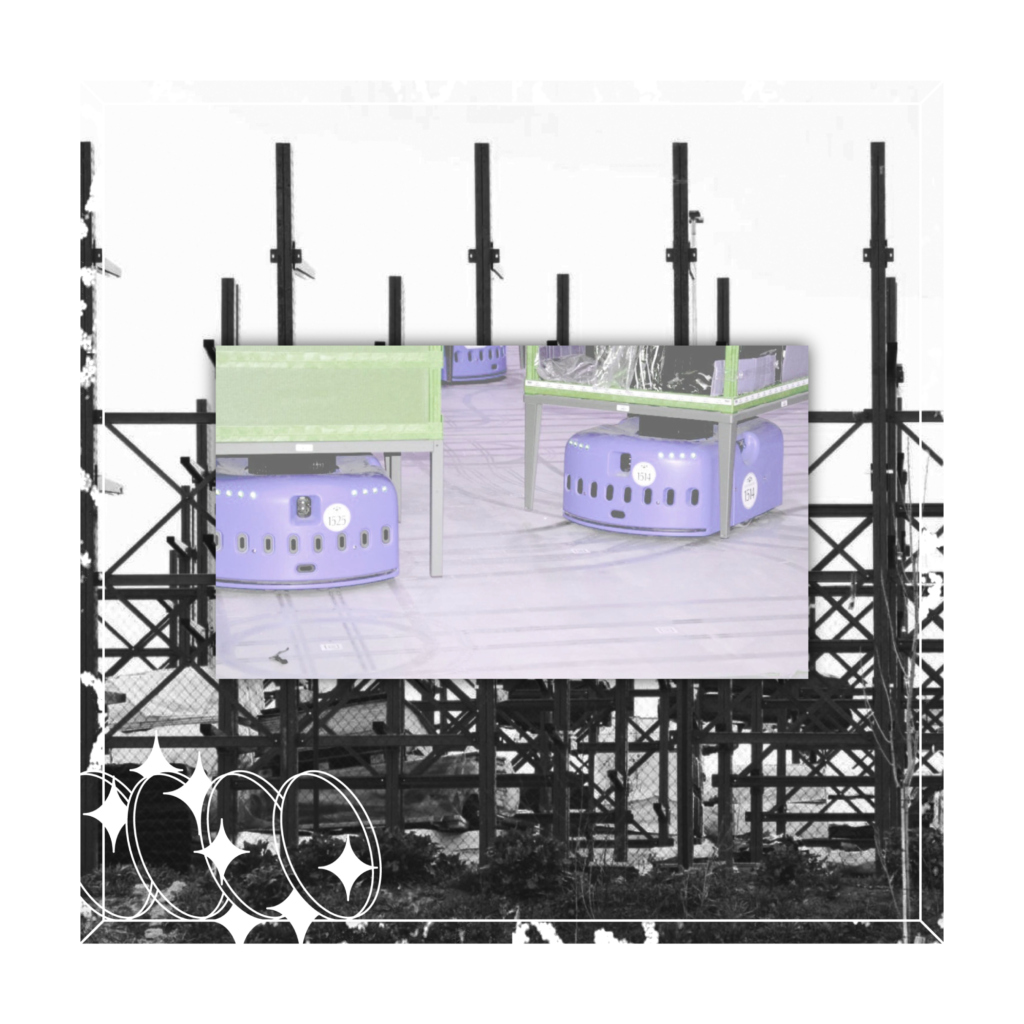
I centri di distribuzione europei di Amazon si trovano tutti in campagna, in aree periferiche vicine a grandi centri urbani: posti in cui il potere economico delle amministrazioni è basso, che non vedono l’ora di accogliere un nuovo business e che sono felici di essere colonizzati. La condizione periferica è profondamente integrata nella filosofia del dominio di Amazon, tanto in senso spaziale quanto in senso economico-sociale. Parliamo della periferia di un’Europa che oggi sembra completamente urbanizzata, come teorizzato da Neil Brenner che, riprendendo l’idea di “mesh” di Henri Lefebvre, sostiene che una forma infinita di urbanizzazione sia come una colla che intrappola la periferia tra le infrastrutture pesanti, come autostrade e ferrovie, e le repentine costruzioni di nuove città ai margini degli antichi centri urbani. Le vecchie cascine vengono trasformate in centri di produzione intensiva, e più recentemente di distribuzione. Pannelli di cemento prefabbricati prendono il posto di mattoni e pietre; un brulichio incessante si sostituisce al silenzio dei pascoli; un’armata schizofrenica di camion soppianta i trattori. E la logistica assume il controllo delle periferie.
Il centro di distribuzione – l’edificio in cui gli articoli comprati online vengono raccolti, stoccati, e inviati ai consumatori grazie al supporto del potere computazionale dei data center – è l’architettura meno iconica ma più rappresentativa del neoliberalismo al potere. Questa architettura, marginale a livello spaziale e poco nota, è diventata centrale nelle nostre vite da quando il fenomeno degli e-commerce ha rivoluzionato le abitudini di consumo alla fine degli anni Novanta. Fino a quel momento, l’immagine globale degli acquisti era il centro commerciale, che, pur agonizzante, continua ancora oggi a dominare le periferie. I primi centri commerciali comparvero in Europa subito dopo la Seconda guerra mondiale con la promessa del nuovo stile di vita importato dagli Stati Uniti, ma la vera “mallification” delle periferie europee raggiunse il picco tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, con un’accelerazione neoliberale che cambiò completamente la relazione tra spazi pubblici e privati in architettura. Ma anche se i centri di distribuzione sono prodotti dalla stessa economia neoliberista che generò i centri commerciali, le due architetture sono ai poli opposti.
Il centro commerciale, teorizzato e progettato per primo da Victor Gruen, un architetto ebreo emigrato dall’Austria a New York negli anni Cinquanta, è un catalizzatore per la classe media, che si ritrova lì per cercare uno spazio pubblico che desidera e a cui non ha accesso nei sobborghi dove vive. Il centro commerciale riproduce, con le sue insegne, le vetrine e gli ornamenti, il centro storico, adattato alla nuova realtà domestica indoor grazie a una serie di comfort, come ascensori e aria condizionata. Un centro di distribuzione invece è completamente recintato e sotto continua videosorveglianza, uno spazio apparentemente dimenticato dove lavorano solo pochi, alienati, guardiani delle macchine. A differenza dei centri commerciali, i centri di logistica non hanno nulla a che fare con la città e la domesticità: sono architetture a misura di macchina costruite per essere ignorate dai consumatori, che ora possono comprare “tutto” dalle loro case con un paio di click.
Il centro commerciale è un catalizzatore per la classe media, che si ritrova lì per cercare uno spazio pubblico che desidera e a cui non ha accesso
Il centro di distribuzione diventa così uno dei simboli principali dell’era del liberalismo post-fordista — un’era generata da innovazioni tecnologiche come il nastro trasportatore o il carrello elevatore. Lo sviluppo più recente del magazzino logistico, invece, dipende totalmente dall’uso di macchine autonome governate dagli algoritmi, sistemi complessi che lavorano con un’enorme quantità di dati per rendere le catene logistiche il più efficienti possibili. La più famosa tra queste macchine è probabilmente Kiva: un piccolo robot arancione che sposta gli scaffali nei dei centri di riempimento Amazon secondo le regole di un algoritmo che calcola la disposizione più produttiva del layout degli scaffali mobili. Gli algoritmi governano il comportamento di ogni singolo componente dei sistemi, e anche il funzionamento delle loro aggregazioni. Non c’è un’unica autorità in capo al movimento; le “gerarchie di rete e la crescita nodale sono prodotte da singoli attori che rispondono a prezzi, tempi di attesa, e vincoli astratti ma fisici come lo spazio nel magazzino e la disponibilità di carico.” Questo sistema trasforma il suolo nell’unica superficie rilevante di tutti gli elementi architettonici: l’espansione orizzontale è l’unica soluzione possibile.
Così organizzati, i centri di distribuzione possono ipoteticamente espandersi all’infinito sulle distese asfaltate delle periferie, a seconda dei bisogni del mercato. Non è assurdo immaginare un futuro in cui le periferie si trasformino in centri di distribuzione a perdita d’occhio, dove macchine governate dagli algoritmi danzano un’incessante coreografia di scambi per soddisfare gli indolenti consumatori urbani; un futuro in cui i robot siano l’esercito delle compagnie logistiche che marciano sul suolo europeo per conquistare i consumatori. Le periferie europee sembrano sempre più plasmate dall’apparato logistico, e l’automatizzazione è l’ultimo architetto di questi territori marginali.