L'intraducibile
Rinunciare a comunicare significa condannarci all’isolamento, all’autoreferenzialità, al conflitto sociale.
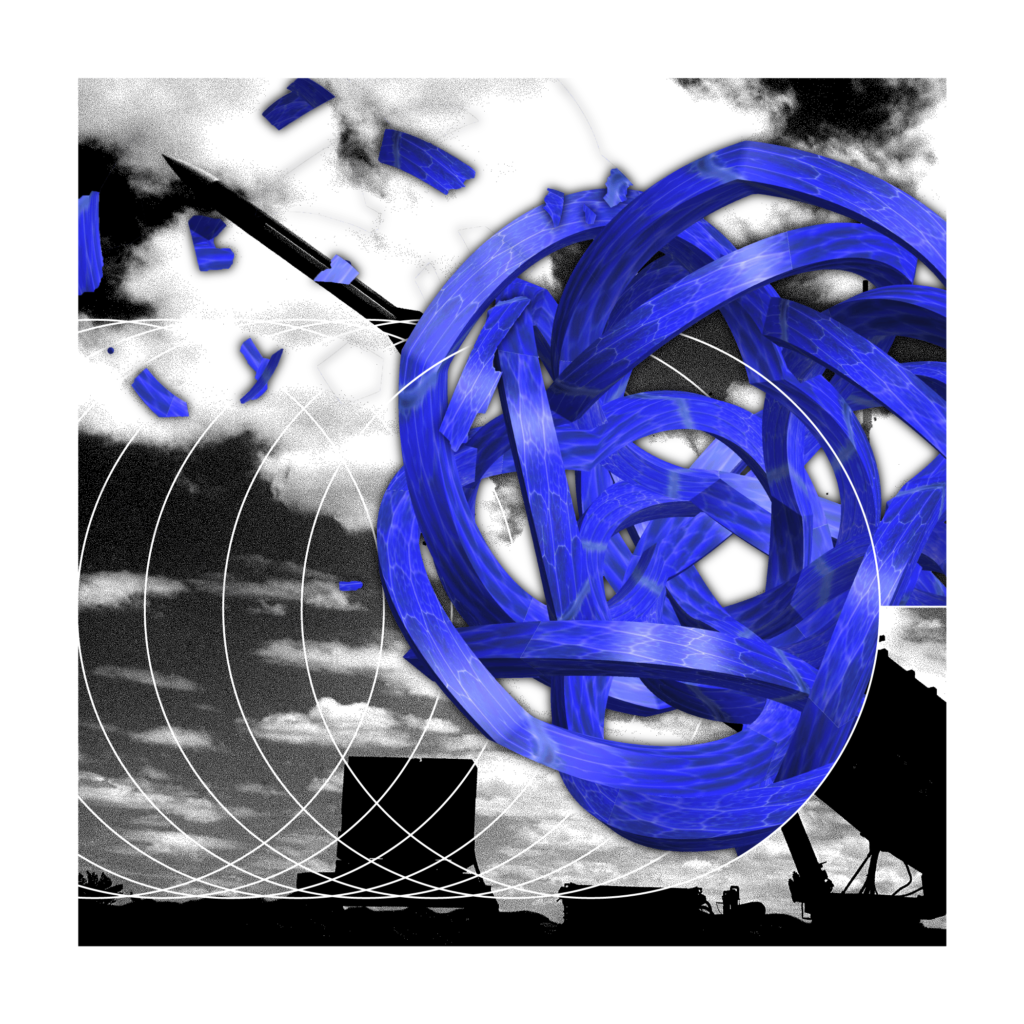
Le parole hanno grandi poteri: se usate con lucidità, possono plasmare la visione del mondo di chi le ascolta. Se usate d’istinto, possono rivelare falle di coscienza.
Lo vediamo spesso nei discorsi politici: George W. Bush, durante un evento presso la Southern Methodist University tenutosi a metà maggio, ha avuto un lapsus più che freudiano definendo “ingiustificata e brutale” l’invasione dell’Iraq. Per poi correggersi: intendeva dell’Ucraina, ovviamente.
Lo vediamo anche nel logorante attacco ai (rosicati) diritti che le donne hanno ottenuto con fatica nella seconda metà del ‘900. Sono decenni che i lobbisti americani pro vita, nel loro programmatico tentativo di ribaltare la sentenza Roe v Wade, plasmano una lingua che supporti il loro punto di vista, ma che non ha basi fattuali. L’esempio più eclatante è quello della “partial-birth abortion”, una pratica che si riferisce a un termine inventato e non medico ma che i pro vita sono riusciti comunque a bandire con una legge del 2003 — un tassello in più per restringere l’accesso all’aborto delle donne. E ci stanno riuscendo.
Parole errate, faziose, scelte con cura, che hanno un impatto per generazioni e dilaniano società già dilaniate. Parole che raccontano un presente di crisi cicliche, di emergenze su emergenze che non ci permettono di vedere lucidamente, di parlare lucidamente. Di analizzare. Di pensare. Di progettare. Gli algoritmi e la tecnologia sono solo uno strato che si sovrappone a questo caos, fomentandolo.
Se non possiamo comunicare, capirci, empatizzare, non riusciremo mai a tradurre davvero le nostre esperienze e i nostri pensieri in un modo che arrivi davvero agli altri. Ci condanniamo all’isolamento, all’autoreferenzialità, al conflitto sociale.
Le parole però possono anche essere giuste: e ora più che mai ci servono parole giuste, che ci aiutino a creare un terreno comune, condiviso, per costruire società più sane — o almeno meno malate, meno schizofreniche, meno polarizzate, meno irrisolte. A pensarci bene, si tratta di uno sforzo che facciamo ogni giorno: comunicare con gli altri è un gioco in cui crediamo ciecamente che gli altri ci capiranno, pur sapendo che non potrà mai succedere appieno. Sono un tentativo, che sappiamo già essere vano, di abbattere una barriera fisica, mentale, emotiva. Un bisogno atavico che si accartoccia su sé stesso, senza mai riuscire nel suo intento: perché i mondi, interiori ed esteriori, sono tutti incomunicabili.
Nel quarto numero di Istmo, raccontiamo altri esempi del farsi atto di questo bisogno umano innato. L’intraducibilità passa da tanti canali, non solo dalla parzialità delle parole, che non riescono a contenere il tutto specie quando il tutto è in continua trasformazione, ma anche dal sovraccarico di informazioni, che con la pandemia sta mandando molti di noi in una sorta di collasso psichico e in un rifiuto dell’informazione stessa — quasi una rinuncia a capire.
Attraversiamo con questo numero quello che tutti e tutte, talvolta, attraversiamo nella quotidianità: il permanere inconscio di matrici patriarcali o banalmente maschili nelle nostre parole nel pezzo di Giorgia Maurovich; l’incomunicabilità del nostro essere nella sua complessa sedimentazione con Niccolò Carradori; l’impoverimento nella quantità di informazioni portate dai semi alla base della nostra dieta nelle immagini di Anguilla Anguilla; il dolore come condanna all’incomprensione nel racconto di Melissa Geczy.
In questo panorama grigio, però, c’è una nota di speranza: che viene, come in certa poesia del Novecento, dallo sforzo naturale, inconscio, che tutti i giorni facciamo per rompere questo silenzio ed entrare in contatto con l’altro. E da qui, con questa issue, vogliamo ripartire.


